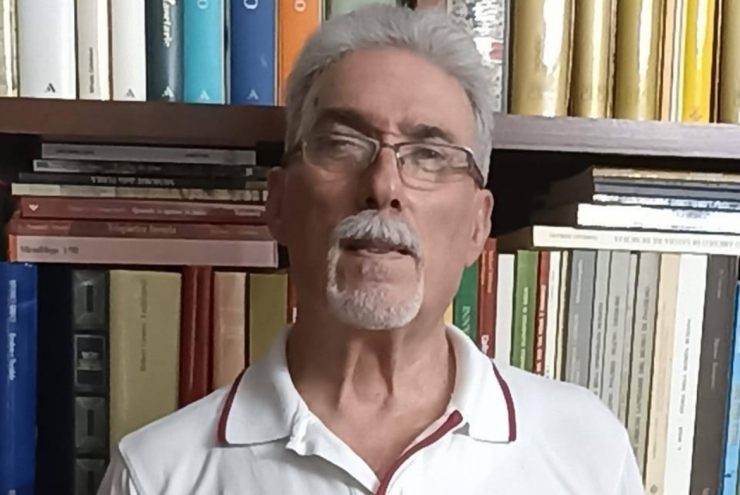Più che un articolo, un manifesto culturale e spirituale da assaporare parola per parola. E’ il mirabile pezzo di Alessandro Giuli uscito su Il Foglio il 23 novembre 2015, replicato qui di seguito.

In un’alba di fine agosto fra le creste montane dell’Abruzzo ancora intatto, un cucciolo di lupo sbuca all’improvviso dalla faggeta, annunciato da un turbinìo di ringhi e scrosci di foglie. Caracolla impettito sotto gli occhi sgomenti di un uomo nascosto a pochi metri, avanza stringendo nella mascella la testa sanguinante di una cerva appena sbranata dagli adulti, gettata fra i lupatti come trofeo di una contesa per iuniores dalla quale nascerà un giovane capo, una gerarchia, il seme regale del branco che verrà. Il cucciolo vincitore scruta l’orizzonte, le orecchie mobili ad auscultare sussurri e vibrazioni di un cerchio invisibile, come per indovinare un richiamo, quasi a cercare l’assenso del capostipite, il dio Lupo. “Era stato l’insieme dello sguardo innocente di quel lupo con l’espressione serena della cerva, che sembrava addormentata, a sconvolgermi. Non c’era alcuna malvagità in quella scena; sembrava quasi un gioco infantile, eppure spiegava tutto: era la quintessenza della selvaticità. Una vera e propria epifania ecologica. La vita che nasce dalla morte”. Così scrive il protagonista di questa visione, il fotografo e biologo Bruno D’Amicis, nel suo formidabile diario per immagini intitolato “Tempo da lupi” (un lungo viaggio fra appostamenti e incontri lupeschi documentato con testo e foto di raro splendore, appena pubblicato da Lit edizioni).
Quelle stessa scena, ma nella fissità dei segni che parlano al cuore, io l’avevo vista pochi anni fa in una necropoli etrusca della Tuscia laziale. Un’immagine nascosta all’occhio profano, scolpita in rilievo sulla parete di un corridoio tombale (dromos) gentilizio, inondata al mezzogiorno da un raggio d’oro sull’ocra del tufo e listata dalla porpora dei muschi autunnali: un cervo addentato al collo da un lupo possente, sontuosamente chiomato, leonino addirittura. Quintessenza, anche questa, di un messaggio semplice e fatale: la fine del secolo lunare-etrusco nell’alba del ciclo marziale-romano, il passaggio di un testimone tra civiltà fraterne, ma pure – per chi sa leggere il volto nascosto dei simboli – l’intima solidarietà della Luna e del Sole, perché il cervo è sacro a Diana, signora della luce manifesta, e il lupo è l’animale guida di Apollo, protettore lucente dei Troiani-Romani.
Ma chi sono i lupi? I lupi siamo noi, se solo volessimo ancora. Lupi raptores, come ricorda Virgilio nel secondo canto dell’Eneide, quando Troia cade fiammeggiando e il pio Enea azzarda un contrattacco eroico, prologo dell’adunata con cui il figlio di Venere e Anchise lancerà per mare la sfida del ritorno in Italia per i discendenti del tirreno Dardano: “Così si accrebbe nell’animo di quei giovani il furore. / Poi, simili a lupi predatori nell’oscura nebbia / che ciechi spinge una fame furiosa, e i cuccioli abbandonati / aspettano con le fauci strette, ci avventiamo fra i dardi…” (trad. Luca Canali). Lupi raptores, gli Eneidi sbarcheranno nel Lazio e troveranno per alleati gli Arcadi di Evandro, devoti ad Apollo-Lupo, e gli Etruschi di Tarconte che Virgilio chiama Licii, ovvero i Lupi: popoli antichissimi effigiati dal totem ferino. “La descrizione virgiliana dei Lupi in azione durante la presa di Ilio – scrive Corrado Cardoso nel suo “Lupi, guerrieri e sciamani alle origini dei Latini”, Palombi editori, 2010 – risente della circostanza per cui i Troiani, còlti di sorpresa dall’attacco notturno degli Achei, non hanno avuto il tempo di far risuonare gli strumenti”, ovvero le tubae e i corni che, a imitazione dell’ululato, innescano “la trance bellica perché il Pur – il Fuoco Sacro (Ermes/Thermos) che annuncia gli dèi – corrisponde al fenomeno fisico dell’alterazione respiratoria e del battito cardiaco e, quindi, della pressione sanguigna che induce calore”. Ma “in mezzo al combattimento, all’eccidio dei propri cari e all’incendio della città i Lupi raptores sono stati comunque raggiunti dal dio, anche senza i gesti rituali… Sono anzi bastate poche parole di incitamento da parte dello sciamano guerriero Enea per ottenere un rilevante effetto”. Così cacciano i lupi, e il loro cacciare è uno spettacolo sacro, così combattono gli uomini-lupo italici cantati da Virgilio, guidati dagli anziani che serrano la loro canizie negli elmi di guerra, “… e difendono il capo con fulvi / berretti di pelle di lupo; imprimono nude orme / del piede sinistro; l’altro, un grezzo stivale lo ricopre” (Eneide, VII, 688-690). Lupi per natura ancestrale (la Lupa mansuefatta allattante Romolo e Remo), guerrieri per diritto di nascita (Mars Pater) e rito di passaggio, come suggerisce lo storico delle religioni Mircea Eliade nel suo “Lo sciamanesimo e le tecniche dell’estasi” (in Italia per le Edizioni Mediterranee): “Sono soprattutto le società segrete aventi per base una iniziazione guerriera – nella misura in cui è lecito chiamar sciamaniche le loro estasi e le loro cerimonie frenetiche – che hanno sviluppato e reinterpretato il simbolismo e la magia del cane e del lupo”. Fu così anche fra gli Alfhednar, “gli uomini dalla pelle di lupo” dell’alto medioevo germanico, e nelle Americhe dei nostri cugini atlantidei, lì dove i “Soldati-Lupo” Cheyenne furono l’ultima delle sette società guerriere dotate di poteri magici sugli spiriti del tuono e della bufera, impegnate a “difendere l’accampamento contro gli assalti e fungere da polizia durante le cacce ai bufali e gli sconfinamenti nei territori nemici”, come scrive il più grande naturalista americano, Barry Lopez, nel suo magnifico “Lupi e uomini”, (1978, pubblicato in Italia da Piemme, l’ultima edizione è di quest’anno).
Un antico proverbio cinese dice che “tutto l’animale è nell’uomo, ma non tutto l’uomo è nell’animale”. E io non voglio certo dire che l’uomo sia una belva scatenata, in condizioni di normalità – anche se trovo irresistibile la scena in cui il Jack Nicholson di “Wolf, la belva è fuori” (1994), ormai in via di trasformazione licantropica per via di un inatteso, notturno morso lupesco, delimita il proprio territorio pisciando sulle scarpe del giovane rivale James Spader che aveva tentato di scippargli lavoro e amor proprio, poverino… –, come del resto non lo è il lupo, malgrado la cattiva fama di cui ha goduto per tanti secoli, dal declino del mondo antico, perché il lupo è naturaliter pagano. Come ci ricorda Bruno D’Amicis: “La Chiesa ha agito da filtro culturale, trasformando il lupo in allegoria di ingordigia e lussuria, nonché demonizzandolo quale creatura infernale. In tempi così bui… non sorprende il fatto che il lupo, come anche altri elementi della wilderness, potesse rappresentare per l’uomo medievale la sintesi delle forze avverse della natura e il capro espiatorio di tutti i suoi mali… Non ci dimentichiamo che in Italia, per esempio, il lupo è specie protetta solamente dal 1976”. Né dobbiamo dimenticare che il lupo per decenni, prima di riguadagnare la sua autenticità o wilderness, e a tutto discapito dei suoi odiatori intenti a farne un (inesistente) predatore dell’uomo, è stato uno spazzino fra tanti in mezzo ai rifiuti delle nostre periferie paesane, come ha spiegato in forma magistrale il migliore ministro dell’Ambiente che l’Italia non ha mai avuto, ovvero Luigi Boitani (“Dalla parte del lupo. La riscoperta scientifica e culturale del mitico predatore”, Giorgio Mondadori, 1986). “Esistono due ‘lupi’, uno fantastico e uno reale… Il punto di contatto tra questi due lupi è l’uomo”.
L’aspetto più avvincente del libro di Bruno D’Amicis, che dal febbraio 2012 ha trascorso almeno un ciclo di stagioni appostato fra sassi e forre abruzzesi come un predatore (ma d’immagini), è il suo voler incontrare il lupo in sé ponendosi dal punto di vista dell’animale, il lupo in me: “Volevo provare a vivere l’Appennino un po’ nei loro panni, guardando monti e valli con i loro stessi occhi”. Il risultato è un progressivo processo di identificazione con il lupo e con il suo corteggio di sodali nella catena alimentare (sopra di lui, c’è soltanto l’uomo), ovvero corvi (sacri anche loro ad Apollo!), aquile reali (Giove), grifoni, ghiandaie… e naturalmente cervi e caprioli che svolgono esattamente lo stesso ruolo dei caribù nel Canada settentrionale evocati dai racconti dai sapienti nativi: “Lo spirito del lupo parlerà ai suoi figli, ed essi mangeranno i caribù malati, e deboli e piccoli, così la terra rimarrà a quelli grassi e buoni. E questo è ciò che successe, ed ecco perché il caribù e il lupo sono una cosa sola; perché il caribù nutre il lupo, ma è il lupo che mantiene il caribù forte”. Disse proprio così lo sciamano eschimese Ootek a Farley Mowat, negli anni Sessanta del secolo scorso, quando quest’ultimo si mise a esplorare i ghiacci del profondo nord americano per capire se davvero i lupi dovevano essere sterminati dall’uomo nuovo, altrimenti sedicente vittima dei suoi artigli e delle sue zanne (la risposta fu: no, i lupi bianchi divoravano per lo più topolini selvatici e, appunto, caribù; uomini zero). Ootek, lui sì, poteva sentire il cammino felpato del lupo sul ghiaccio, perché “verso i cinque anni, suo padre, uno sciamano di fama, lo aveva portato in una tana di lupi e lo aveva lasciato lì per ventiquattr’ore, durante le quali egli aveva fatto amicizia e giocato da pari a pari con i cuccioli dei lupi, ed era stato trattato con noncuranza dagli adulti, senza per altro venire molestato” (Farley Mowat, “Il compagno dei lupi”, Longanesi, 1975).
D’Amicis non è soltanto uno dei migliori fotografi italiani in circolazione (e, aggiungo io, anche uno scrittore naturale), è una figura a modo suo attivamente medianica, aperta alla possibilità di parlare col grande spirito della natura. A forza di attendere la manifestazione dei lupi, spiarli nei pressi delle tane dopo la stagione dell’amore (si accoppiano soltanto il maschio e la femmina alpha, da marzo in poi, e dopo 63 giorni nascono 5+6 lupatti la metà dei quali non potrà conoscere più d’una luna), dei luoghi di ritrovo (rendez-vous), di caccia o dispersione, entra nella dimensione dell’ascolto, quello stato dell’essere in cui, secondo Walter Otto, si dilegua l’io storico ed entra in gioco l’essere profondo, il numinoso: ed ecco che la risonanza interiore, la memoria ancestrale, non si fa attendere: “La semplice presenza di grandi carnivori in un certo luogo riesce a scatenare un effetto immediato e profondo nella mente umana. Quando sono consapevole di essere in terra di orsi o sul cammino dei lupi, le mie capacità sensoriali sembrano acuirsi così come l’attenzione si focalizza tutta sul presente. Provo sentimenti di rispetto e sincera umiltà, mai di paura. Mi trovo in un’esaltante incertezza e percepisco anche una comunicazione in qualche modo più intima con l’ambiente circostante, i cui confini e punti di riferimento diventano sempre meno netti e scontati”. Fa bene, D’Amicis, a parlare di “shock primordiale” e a considerarlo come “un privilegio”. Lui sa, e lo fa scrivere al naturalista statunitense Jim Brandenburg nella prefazione al proprio libro, che il successo delle nostre strategie di sopravvivenza negli ultimi cinquantamila anni dipende in larga misura dall’alleanza primigenia, unigenita io direi, dell’uomo con il lupo, l’animale domesticato che più a lungo di qualsiasi altro ci fa compagnia nelle nostre cacce materiali e spirituali. E aggiunge una notazione fecondissima, D’Amicis, quando introduce il concetto di “ecologia della paura” coniato dagli etologi che hanno studiato le modificazioni comportamentali degli ungulati nel parco di Yellowstone: il timore del lupo ne ha ridimensionato l’areale di pascolo a beneficio della ricrescita di arbusti e alberi. Un fenomeno che ha portato Jim Crumley, nel suo “The Last Wolf” (2012), a parlare del lupo come del “pittore delle montagne” perché, predando, restituisce colore, profumo e dunque anima a vegetazioni e paesaggi altrimenti destinati alla sola ruminazione. La paura è importante, utile, se razionalizzata, e D’Amicis ne intuisce il segreto: “Quanti boschi devono essere scampati alla scure dell’uomo, quando questi ha evitato di entrarci per paura del lupo cattivo?”. Fermo restando che i riccioli favolosi di Cappuccetto Rosso non varranno mai alcun lupicidio. E oggi proprio di lupicidio legale, come se non bastassero automobili e avvelenatori o bracconieri, tornano a parlare gli incauti e i malacarne. I lupi sbranano troppe pecore, pastori e allevatori sono esasperati: vanno dicendo così, sia in Francia sia qui, i mezzi di comunicazione allarmisti…
A un certo punto D’Amicis riporta un noto proverbio russo che dice: “Il lupo viene nutrito dai suoi piedi”, e cioè dalla sua straordinaria capacità di percorrere decine di chilometri al giorno e, in caso di dispersione solitaria, fino a duemila chilometri pur di trovare la zona giusta in cui figliare con un’aristolupa e formare un proprio branco (i lupi sono intelligentissimi, affettuosi, ilari, territoriali, feroci soltanto all’occorrenza, monogami e, motivo d’ammirazione massima, non democratici). Per farvi un’idea, osservate la mappa in cui Marco Albino Ferrari (“La via del lupo”, Laterza, 2012) ripercorre il tragitto lungo il quale il lupo appenninico, dai Monti Sibillini alla Valsavarenche svizzera, ha ripopolato la dorsale italiana e l’arco alpino italo-francese. E se cercate un tocco letterario, leggete il racconto in cui Renato Riva (“L’ultimo Rimen. Uomini e lupi in Val di Rhêmes”, Edizioni della Sera, 2012) illumina senza retorica l’inverno di un ex amato capobranco erratico che “un giorno si era scoperto più debole di un suo giovane consimile… aveva evitato la lotta, intuendo la probabile disfatta, e si era piegato… alla ricerca di nuovi spazi, seguendo l’istinto che gli veniva da dentro, senza più la cura degli altri… Sapeva di essere in avanscoperta. Altri lupi, i suoi vecchi, lo avevano fatto per lui negli anni di fuoco. E dove i vecchi dicevano che si poteva stare, davvero si poteva stare. Ora toccava a lui”. E chi altri, come il lupo, se non noi? Noi discendenti del nomadismo pastorale indoeuropeo (qualunque cosa voglia dire “indoeuropeo”), eredi viventi dei pastori-guerrieri italici impegnati nella transumanza e nelle primavere sacre per popolare il cosmo di città ordinate, sacrate al totem della stirpe – come fecero gli Hirpini dalla Sabina, e più ancora i latini-romani Alba Longa sub uberibus lupae, come scrive Tito Livio, le ubera roscide del bianco umore dei primordi tramandato da maestri incogniti – ; sotto alture vegliate da caste sacerdotali come gli Hirpi Sorani del Monte Soratte, ministri del Pater Soranus ovvero l’Apollo “che scende come la notte”. Pastori e lupi, ma non sono nemici ancestrali? Nient’affatto. In antico a Roma, nel mese di febbraio, si celebrava la loro muta e feconda solidarietà in occasione delle feste Lupercalia (archetipo carnevalesco) quando i giovani dell’Urbe ritualizzavano la mitistoria delle origini, fra pelli caprine e invocazioni lupesche.
Nessuno come i pastori conosce il “compare lupo”, sostiene il massaro Cola, il protagonista de “Il tratturo” di Franco Ciampitti (1969), un nemico così famigliare che alla fine perfino i cani pastore, alle volte, chiudono un occhio e gli regalano una pecora pur di evitare la zuffa fratricida, purché s’accontenti e la smetta di fastidiare. Carne, latte e lana, gelo, fatica e ristoro sono la bevanda d’immortalità nel ciclo biologico vitale in cui uomo, lupo, cane e greggi si sostentano vicendevolmente da sempre. D’Amicis coglie da parte dei pastori abruzzesi “una punta di rispetto verso quei predatori così eccezionali” che sono i lupi. Lui s’è fatto amico un allevatore, figlio e padre di pastori, l’ha seguìto nel suo stazzo dai pali alti e robusti con la fitta rete metallica, governato dai collari dentati di otto mastini, e l’ha interrogato sul “compare lupo” aspettandosi forse un piagnisteo come quelli dei giornali. Ma l’allevatore, col suo bastone-scettro e la gravitas di un sovrano dei pascoli, ha risposto: “Il lupo è come il temporale. Non puoi fare nulla per evitarlo, ma se porti con te l’ombrello per lo meno non ti bagni”. L’ombrello non è la lupara, è la prevenzione, la vigilanza sul lupo da parte dell’uomo-lupo, una delle ultime possibili incarnazioni del Vir antico.
Dice: dove vuoi portarci, con tutto questo diorama d’immagini e affabulazioni? A casa, lì dove “il lupo non è un’ombra, ma una luce brillante” (D’Amicis). Per ripartire dai fondamentali, reimparare l’ardore, la prudenza, la saggezza tradizionale dei lupi. O forse la verità pronunciata dall’uomo-lupo Jack Nicholson, durante un ricevimento con troppi sospiri radical e gnagnerosi sulle deforestazioni pluviali… “Si potrebbe anche sostenere che il mondo è finito da un pezzo… che l’arte è morta, che siamo stremati, che al posto dell’arte abbiamo una cultura di massa… omosessuali della terza età, donne che vengono violentate dal proprio dentista, che vanno a confidarsi a un talk-show, una profonda e dettagliata analisi sul perché le donne tagliano il pene ai mariti…”. Scorrettissimo! Odo già, odo ancora gli strepiti del veganismo militante, i maestri cantori del grande e tetro esorcismo carnofobico, del genderismo arrabbiato, della climatologia terroristica antinazionale e dell’ecologia paracula (quella delle pale eoliche, per capirci), grassamente speculari alla furia naturicida di certe multinazionali.
Insomma sono arrivato a questo punto: se cercate un modello alternativo alla barbarie che invade e fa strage, prima di rifugiarvi nelle bombe intelligenti (?), riconoscete che il nostro primo problema siamo noi stessi, immemori uomini-lupi, e perciò la soluzione del problema siamo sempre noi uomini-lupi: compagni fedeli e meticolosi alleati dell’ordine divino, come Geri e Freki ai piedi di Odino assiso in trono; oppure tenebrosi ditruttori del nostro cosmo come Fenrir, generato dal malvagio Loki con la gigantessa Angrbodha. Invochiamo dunque i Luperci, figli di Marte, scintille viventi di luce apollinea.
Alessandro Giuli – Il Foglio