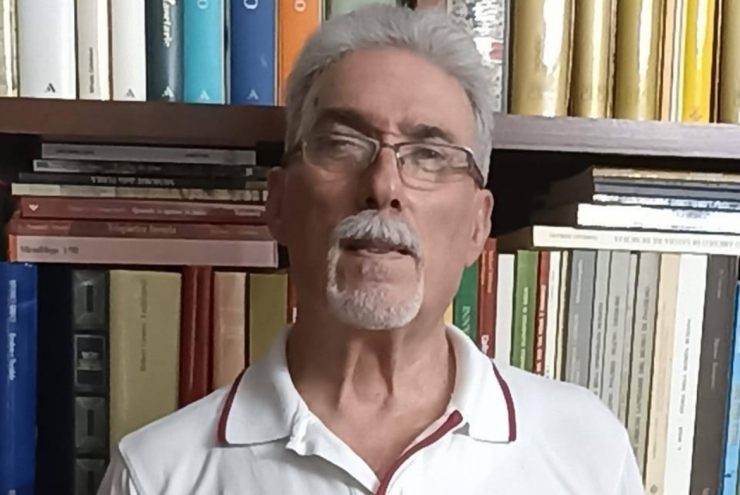Le Metamorfosi di Ovidio. I, 434 – 567: Apollo e Dafne

I, 434 – 567
- Ergo ubi dīluviō tellus lutulenta recenti
- sōlibus aetheriīs altōque recanduit aestū,
ēdidit innumerās speciēs partimque figūrās
rettulit antiquās, partim nova monstra creāvit.
Illa quidem nollet, sed tē quoque, maxime Pȳthon,
tum genuit, populīsque novīs, incognite serpens,
- terror erās: tantum spatiī dē monte tenēbās.
Hunc Deus Arquitenens et numquam tālibus armīs
ante nisi in dammīs capreīsque fugācibus ūsus
mille gravem tēlīs, exhaustā paene faretrā,
perdidit effūsō per vulnera nigra venēnō.
- Nēve operis fāmam posset dēlēre vetustās,
instituit sacrōs celebrī certāmine lūdōs
Pȳthia perdomitae serpentis nōmine dictōs.
Hīc iuvenum quīcumque manū pedibusque rotāve
vīcerat, aesculeae capiēbat frondis honōrem;
- nōndum laurus erat, longōque decentia crīne
tempora cingēbat dē quālibet arbore Phoebus.
Prīmus amor Phoebī Daphnē Pēneia: quem nōn
fors ignāra dedit, sed saeva Cupīdinis īra.
Dēlius hunc nūper, victō serpente superbus,
- vīderat adductō flectentem cornua nervō
‘quid’ que ‘tibī, lascīve puer, cum fortibus armīs?’
dixerat, ‘ista decent umerōs gestāmina nostrōs,
quī dare certa ferae, dare vulnera possumus hostī,
quī modo pestiferō tot iugera ventre prementem
- strāvimus innumerīs tumidum Pȳthōna sagittīs.
Tū face nesciō quōs estō contentus amōres
inrītāre tua nec laudes adsere nostrās.’
Fīlius huic Veneris ‘fīgāt tuus omnia, Phoebe,
tē meus arcus’ ait, ‘quantōque animālia cēdunt
- cuncta deō, tantō minor est tua glōria nostra.’
Dixit et ēlīsō percussīs āëre pennīs
inpiger umbrōsā Parnāsī constitit arce
ēque sagittiferā prompsit duo tēla pharētrā
dīversōrum operum: fugat hōc, facit illud amōrem;
- quod facit, aurātum est et cuspide fulget acūta,
quod fugat, obtusum est et habet sub harundine plumbum
hoc deus in nymphā Pēnēide fixit, at illo
laesit Apollineās traiecta per ossa medullās:
prōtinus alter amat, fugit altera nomen amantis
- silvārumque latēbris captivarumque ferārum
exuviīs gaudens innuptaeque aemula Phoebes;
vitta coercēbat positōs sine lege capillōs.
Multī illam petiēre, illa āversāta petentes
inpatiens expersque virī nemora āvia lustrat
- nec, quid Hymen, quid Amor, quid sint cōnūbia, cūrat.
Saepe pater dixit ‘dēbēs mihi, nāta, nepōtes’:
illa velut crīmen taedās exōsa iugālēs
pulchra verēcundō subfūderat ōra rubōre
- inque patris blandīs haerens cervīce lacērtis
‘dā mihi perpetuā genitor carissime,’ dixit
‘verginitāte fruī: dedit hōc pater ante Diānae.’
Ille quidem obsequitur: sed tē decor iste, quod optās,
esse vetat, vōtōque tuō tua forma repugnat.
- Phoebus amat vīsaeque cupit cōnūbia Daphnes,
quodque cupit, sperat, suaque illum orācula fallunt;
utque levēs stipulae demptīs adolentur arīstīs,
ut facibus saepēs ardent, quās forte viātor
vel nimis admōvit vel iam sub lūce relīquit,
- sic Deus in flammās abiit, sic pectore tōto
ūritur et sterilem sperandō nūtrit amōrem.
Spectat inornātōs collō pendēre capīllōs
et ‘quid, sī cōmantur?’ ait; videt igne micantes
sīderibus similēs oculōs, videt oscula, quae nōn
- est vīdisse satis; laudat digitōsque manūsque
bracchiaque et nūdōs media plus parte lacērtōs:
sī qua latent, meliōra putat. Fugit ōcior aurā
illa levī neque ad haec revocantis verba resistit:
‘nympha, precor, Pēnēi, manē! non insequor hostis;
- nympha, manē! sīc agna lupum, sīc cerva leōnem,
sīc aquilam pennā fugiunt trepidante columbae,
hostēs quaeque suōs: amor est mihi causa sequendī!
mē miserum! nē prōna cadās indignave laedī
crura notent sentēs et sim tibi causa doloris!
- Aspera, quā properās, loca sunt: moderātius, ōrō,
curre fugamque inhibē, moderātius īnsequar ipse.
Cui placeās, īnquīre tamen: nōn īncola montis,
nōn ego sum pāstor, nōn hīc armenta gregēsque
hōrridus observō. Nescīs, temerāria, nescīs,
- quem fugiās, ideōque fugīs: mihi Delphica tellūs
et Claros et Tenedos Patarēaque rēgia servit;
Iuppiter est genitor; per mē, quod eritque fuitque
estque, patet; per mē concordant carmina nervīs.
certa quidem nostra est, nostra tamen ūna sagitta
- certior, in vacuō quae vulnera pectore fēcit!
Īnventum medicīna meum est, opiferque per orbem
dīcor, et herbarum subiecta potentia nōbīs.
Ei mihi, quod nūllīs amor est sanābilis herbis
nec prōsunt dominō, quae prōsunt omnibus, artēs!’
- Plūra locutūrum timidō Pēnēia cursu
fūgit cumque ipsō verba īnperfecta relīquit,
tum quoque vīsa decens; nudābant corpora ventī,
obviaque adversās vibrābant flāmina vestēs,
et levis īnpulsōs retrō dabat aura capillōs,
- auctaque forma fuga est. Sed enim nōn sustinet ultrā
perdere blanditiās iuvenis deus, utque monēbat
ipse Amor, admissō sequitur vestīgia passū.
Ut canis in vacuō leporem cum Gallicus arvō
vīdit, et hīc praedam pedibus petit, ille salūtem;
- alter inhaesūrō similis iam iamque tenēre
spērat et extentō stringit vestīgia rostrō,
alter in ambiguō est, an sit conprensus, et ipsīs
morsibus ēripitur tangentiaque ōra relinquit:
sīc deus et virgo est hīc spē celer, illa timōre.
- quī tamen insequitur pennīs adiūtus Amōris,
ōcior est requiemque negat tergōque fugācis
inminet et crīnem sparsum cervīcibus adflat.
Vīribus absumptīs expalluit illa citaeque
victa labōre fugae spectans Pēneidās undās
- ‘fer, pater,’ inquit ‘opem! sī flūmina nūmen habētis,
quā nimium placuī, mutandō perde figūram!’
vix prece fīnitā torpor gravis occupat artus,
mollia cinguntur tenuī praecordia librō,
- in frondem crīnēs, in rāmos bracchia crescunt,
pes modo tam vēlox pigrīs rādīcibus haeret,
ōra cacūmen habet: remanet nitor ūnus in illa.
Hanc quoque Phoebus amat positāque in stīpite dextrā
sentit adhūc trepidāre nōvō sub cortice pectus
- conplexusque suīs rāmōs ut membra lacertis
oscula dat lignō; refugit tamen oscula lignum.
Cui Deus ‘at, quoniam coniunx mea non potes esse,
arbor eris certē’ dixit ‘mea! semper habēbunt
tē coma, tē citharae, tē nostrae, laure, pharetrae;
- tū ducibus Latiīs aderis, cum laeta Triumphum
vōx canet et vīsent longās Capitōlia pompās;
postibus Augustīs eadem fīdissima custōs
ante fores stabīs mediamque tuēbere quercum,
utque meum intonsis capūt est iūvēnāle capillīs,
- tū quoque perpetuōs semper gere frondis honōres!’
fīnierat Paean: factīs modo laurea rāmīs
adnuit utque capūt vīsa est agitasse cacūmen.

Traduzione
La terra, ricoperta di fango dal recente diluvio, non appena fu riscaldata dal sole etereo e dal suo forte calore, generò molte specie, recuperando in parte le forme degli antichi animali prima del diluvio e creando in parte nuovi mostri. Anche se la terra non ne aveva l’intenzione, allora ti generò e tu, serpente misterioso, fosti il terrore dei nuovi popoli: tanto era grande la zona montuosa che occupavi.
Il Dio Arciere, Apollo, quasi esaurendo la sua faretra, uccise questo violento mostro spargendone il nero veleno per le ferite inflitte da mille frecce, che prima aveva usato solo contro i daini e le capre. E affinché il tempo non potesse cancellare la fama delle sue gesta, istituí i giochi sacri con la famosa competizione, chiamati Pitici dal nome del serpente sconfitto. In questi giochi chiunque tra i giovani vincesse con le mani, con i piedi o con i carri, riceveva l’onore della corona di Esculapio; non si usava ancora la corona d’alloro e Febo cingeva la sua testa decorata dalla lunga chioma con una corona fatta da qualunque tipo di pianta.
Dafne di Peneo fu il primo amore di Febo: non accadde per puro caso, ma per il violento impeto di Cupido. Il Delio, insuperbito per la recente vittoria sul serpente, quando vide Cupido che fletteva le estremità dell’arco teso gli disse: ‘Insolente ragazzino, che vuoi fare con quelle armi poderose? Quelle si addicono a spalle come le mie: io posso ferire mortalmente le belve feroci e i nemici ed ho appena abbattuto con molte frecce il terribile Pitone, mentre opprimeva con il suo ventre un’enorme distesa di campi. Tu invece accontentati di accendere con la torcia non so quali amori ma non arrogarti le lodi che spettano a me.’ Questi, il figlio di Venere, disse: ‘Febo, il tuo arco può trafiggere ogni cosa, ma il mio arco trafiggerà proprio te e la tua gloria è tanto inferiore alla mia quanto tutti gli animali sono inferiori ad un dio.’ Appena pronunciò queste parole, fendendo l’aria con il battito d’ali, solerte si pose in piedi sull’ombroso Monte Parnaso e trasse dalla faretra due frecce a diverso effetto: una faceva rifiutare l’amore, l’altra invece faceva innamorare; la freccia che faceva innamorare era d’oro splendente con una punta acuta, mentre quella che causava il rifiuto dell’amore era arrotondata con piombo nell’asta. Il Dio trafisse Dafne, la ninfa figlia di Peneo con quest’ultima, mentre con la prima trafisse il midollo di Apollo attraverso le ossa: immediatamente questi s’innamorò, ma l’altra fuggì dall’amante senza nemmeno volerne sapere il nome, preferendo, come la vergine sorella di Febo, i nascondigli nei boschi ed i trofei delle belve che cacciava; una fascia le raccoglieva i capelli spettinati. Molti la desideravano, ma lei tenendosi libera, dopo aver sbrigativamente rifiutato i pretendenti, errava nelle foreste impervie e non si curava di che cosa fossero Imeneo, Amore e matrimonio. Molte volte il padre le aveva detto: ‘mi devi dare dei nipoti’: ma lei, che odiava le fiaccole nuziali come se fossero un crimine, si arrossiva di pudore nel bel volto e abbracciata al collo del padre gli diceva lusinghiera: ‘Carissimo papà, permettimi di restare vergine per sempre: anche il padre di Diana le concesse questo desiderio. Egli accettò, ma proprio quella tua bellezza ti vietò di essere ciò che desideravi e il tuo aspetto resistette a questo voto. Febo si era innamorato di Dafne e dopo averla vista voleva congiungersi a lei sperando di ottenere ciò che desiderava, ingannato dai suoi propri oracoli; e come la lieve paglia separata dalle spighe viene bruciata, e come le siepi ardono, quando un viandante per caso avvicina troppo la torcia o la lascia là, così il Dio si infiammò d’amore e tutto il suo petto andò in fiamme e fomentato con la speranza di un amore in realtà sterile. Il Dio le guardava i capelli disadorni scendere lungo il collo e diceva: ‘Come sarebbero se fossero pettinati?’; le vedeva gli occhi che scintillavano di fiamme simili alle stelle, vedeva le sue labbra, della cui sola vista non si accontentava, e lodava le sue dita, le sue mani, le sue braccia e le sue spalle, nude per più di metà: se qualcosa era celato, lo immaginava ancora più bello. Ma lei scappava più velocemente di una brezza leggera né si fermava al suo richiamo: ‘Ninfa, figlia di Peneo, ti prego, resta! Non ti seguo come nemico; aspetta ninfa! Così scappa l’agnello dal lupo, la cerva dal leone, così scappano le colombe con le piume tremanti dall’aquila, ognuno dai suoi nemici: ma la ragione del mio inseguimento è l’amore! Misero me! Attenta a non cadere, che i rovi non ti graffino ignobilmente le gambe e ti facciano del male! I luoghi per i quali ti affanni sono impervi: per favore corri più piano, trattieni la tua fuga, io stesso ti inseguirò più lentamente. Ma chiediti almeno chi sia colui che ti sta seguendo! Non sono un montanaro, non sono un pastore, qui io non sto custodendo imbruttito mandrie e greggi. Tu non lo sai, temeraria, non lo sai da chi stai fuggendo e continui a fuggire proprio perché non lo sai: mi sono serve le terre di Delfi, di Claro, di Tenedo e della Patarea; Giove è mio padre; attraverso di me si manifesta ciò che fu, ciò che è e ciò che sarà. Grazie a me le corde degli strumenti suonano in armonia. La mia freccia è sicura, ma ancora più sicura è quell’unica freccia che mi ha ferito nel petto vuoto! Io ho inventato la medicina, e sono chiamato il soccorritore del mondo ed ho il dominio dei poteri delle erbe. Povero me, perché l’amore non si può guarire con nessun’erba. Le arti che aiutano tutti, non possono aiutare il loro signore.” La figlia di Peneo con una paurosa corsa continuava a scappare da lui che voleva parlarle e lo lasciava con i suoi discorsi a metà, ma sembrava bella anche allora; il vento la spogliava, le brezze che le venivano incontro scuotevano le vesti e l’aria le dava leggere spinte ai capelli muovendoli indietro e la sua bellezza cresceva nella fuga. Ma il giovane Dio non sopportava più di perdere tempo in lusinghe e, come ammoniva lo stesso Amore, seguiva le orme della giovane con passo affrettato. Come un cane da caccia che ha visto una lepre in un campo deserto e che corre dietro la preda, mentre questa cerca la salvezza; in quella situazione l’inseguitore si aspetta in ogni momento di catturare la preda e tiene il muso puntato sulle orme, mentre l’altra è in difficoltà, temendo di essere catturata e evita i suoi morsi e si sottrae alle fauci che cercano di afferrarla: così accadeva al Dio ed alla vergine, il primo veloce, alimentato dalla speranza, la seconda dalla paura. Egli però era più veloce, perché era incalzato ed incitato dalle ali di Amore, e senza darle tregua raggiunse le spalle della fuggitiva e ormai aveva il suo fiato sul collo dai capelli sparsi. Lei, abbandonate le forze, impallidì e vinta dalla stanchezza della estenuante fuga, guardando le onde del Peneo disse; ‘Padre, aiutami! Fiumi, se siete divini, fatemi perdere la mia forma, che non mi è mai piaciuta!’ Non appena terminò la preghiera, un pesante torpore le investì gli arti: i morbidi seni furono cinti da una tenue corteccia, i capelli si trasformarono in foglie, le braccia crebbero a forma di rami, i piedi prima tanto rapidi si fissarono come pigre radici, il volto divenne la cima dell’albero: in lei rimase soltanto la bellezza.
Febo continuava ad amarla anche così e dopo aver posato la sua mano destra sul tronco sentiva ancora battere il petto sotto la nuova corteccia e abbracciati i rami con le sue braccia, come se fossero arti, ne baciava il legno; ma anche così il legno continuava ad evitare i baci. E il Dio le disse: ‘poiché non puoi essere mia sposa, sarai certamente il mio albero! I miei capelli, le mie cetre, le mie frecce sempre ti avranno, Lauro; tu sarai con i duci del Lazio, quando la voce lieta canterà il Trionfo e il Campidoglio contemplerà le lunghe processioni; tu stessa sarai la custode fedelissima nelle porte del palazzo di Augusto, sugli stipiti, e proteggerai la quercia nel mezzo, e come il mio capo è giovanile con i folti capelli, così anche tu per sempre recherai l’onore delle tue fronde.’ Apollo aveva terminato: fece un cenno ai rami appena generati e sembrava che lei avesse agitato la cima come se fosse la testa.
Commento

Dopo il diluvio ed il ripristino del genere umano, narrato nell’episodio di Deucalione e Pirra, Ovidio descrive in termini naturali le metamorfosi degli altri esseri viventi, ricordando come nelle terre infangate del Nilo, quando la piena si ritira, i pastori egiziani trovano nel fango strani animali dall’aspetto inquietante. La terra si ripopola naturalmente, sia recuperando gli animali che esistevano prima del cataclisma, sia generando nuove forme di vita, tra le quali il terribile mostro Pitone. Per Ovidio dunque la natura non era necessariamente “buona”: era facile nell’antichità morire in balia dei fenomeni naturali come tempeste, incendi, inondazioni o imbattersi in belve feroci come leoni, orsi, serpenti. Pensandoci bene, anche oggi madre natura, benigna sotto molti aspetti, può metterci in pericolo in mille modi; tuttavia la nostra consapevolezza di aver violato l’ordine naturale con lo sfruttamento delle risorse e l’inquinamento ci benda gli occhi fino ad affermare che tutto ciò che è naturale è anche buono. In realtà, ancora oggi godiamo di un argine razionale apollineo contro gli aspetti negativi della natura. Per esempio, senza vaccini saremmo in balia dei più piccoli e pericolosi mostri naturali, i virus. Se consideriamo che i vaccini sono un prodotto medico, legati quindi all’azione di Esculapio-Apollo, ci rendiamo conto che Apollo continua a difenderci e ad armonizzare con le sue arti l’aspetto caotico della Natura rappresentato da Pitone. Lo stesso concetto di armonia è noetico. È vero che in natura ci sono regolarità importanti, ma l’armonia ha una base completamente matematica, astratta: in natura non esiste la “musica” intesa come successione di suoni sottomessi a rigide regole di rapporti matematici di frequenze arrangiate secondo un certo ritmo.
Il Dio Apollo dunque è la grande figura epica che, in linea con il disegno di Giove, stabilisce l’ordine nel mondo. Persino la sua capacità di vedere il futuro procede dall’armonia celeste, dal percepire dalla sua eternità le proiezioni future che a noi sfuggono, per il nostro vivere in una realtà frammentata.
Ci sarebbero tutte le premesse per un grande monoteismo apollineo, con una divinità capace di mantenere l’ordine, di offrire la salvezza, di presentare la profezia finale. L’Uno, il Sole, la Rivelazione. Eppure l’esaltante epica può essere una trappola mentale, come se la ricerca forsennata della luce solare ci potesse abbagliare a tal punto da non poter più percepire le voragini oscure dell’irrazionale, dove ogni malcapitato può cadere. La mente razionale non ha gli strumenti per identificare ciò che razionale non è. Questa è una lezione magistrale del politeismo, dove forze diverse si compenetrano l’una nell’altra alla ricerca di un equilibrio dinamico, visibile come sequenza di eventi contrastanti nel piano temporale, o di miti paradossali nel racconto poetico. Non ci si scandalizzi dunque del racconto dove un Dio cade vittima di una storia d’amore: in ballo c’è l’eterno confronto tra la forza solare e ordinatrice e la dinamica del principio erotico. Un moccioso, un bambinetto grassottello, munito di arco, quasi una figura comica. La mente lo deride. Ma lui, Eros, Cupìdo, muove il mondo senza fatica: Dei, uomini, animali. Il politeismo accoglie e riconosce la componente erotica ed irrazionale accanto a quella apollinea, senza aver necessità di prendere parte allo scontro, di inventarsi la favola del male che rovina i piani al bene, una favola che introducendo il senso del diabolico, è diabolica nel suo squilibrio e cecità, nella sua alienazione dell’essere umano, nella sua introduzione del senso di colpa legato alla necessaria e naturale sessualità.
Apollo, per uccidere Pitone, ha usato mille frecce, Cupido ne scocca solo una verso Apollo e l’altra verso Dafne: il primo, il Dio che ordina ed armonizza la natura, la seconda, colei che rifiuta l’amore. Quanti piani, quante alleanze, quanti eventi sono mutati a causa dell’amore. Le nostre vite sono state profondamente modificate dalle frecce di Cupido, se non altro per il fatto che esistiamo qui ed oggi come frutto di un atto erotico. Si pianifica la vita razionalmente fino a che uno sguardo, un incontro, un gesto si amplifica nel nostro cervello fino a farci compiere l’irrazionale. Nel racconto di Apollo si passa bruscamente da uno stile epico alla scena elegiaca dell’amante frustrato per l’amore negato, non solo un tema ma addirittura un programma per tutta l’opera di Ovidio, dove lo sforzo per conseguire l’amore non corrisposto genera situazioni con mille sfumature.
Non appena colpito, Apollo si concentra solo sul suo obiettivo, la ninfa Dafne. Non c’è lotta contro Cupido, né resistenza, né risentimento. Apollo sa bene di essere stato colpito dalla freccia, lo dice alla stessa Dafne durante l’inseguimento, ma il potere erotico entra oltre le ossa, dritto nel midollo, nel centro nevralgico, nella personalità. Amore agisce come un’irrefrenabile forza interiore che dona al Dio velocità per raggiungere la sua amata che sta scappando. È una storia nota: quante volte ci siamo sentiti dire – o abbiamo detto – “lascia stare, non è la persona giusta per te”? Ma la consapevolezza della freccia generalmente non devia il corso dell’amante, altrimenti sarebbe una faccenda facile ed i poeti non sprecherebbero fiumi di inchiostro. La descrizione di Dafne attraverso gli occhi dell’innamorato è tanto geniale quanto sensuale: “…vedeva le sue labbra, della cui sola vista non si accontentava, e lodava le sue dita, le sue mani, le sue braccia e le sue spalle, nude per più di metà…”.
Il contrasto con l’epica è al massimo quando Apollo, dopo aver cercato di spiegare alla fuggitiva di non avere cattive intenzioni ma di essersi innamorato, cerca di convincerla svelando i suoi onori. La situazione diventa quasi comica per lo stridente contrasto tra la condizione di Dio e quella dell’innamorato rifiutato.
È lecito parlare così degli Dei? Platone e i filosofi in genere non erano d’accordo e consideravano i miti non educativi. D’altra parte non si può negare il fatto che una seria riflessione possa portare a risultati interessanti, che alla fine arricchiscono la nostra percezione del divino. Il riconoscimento della forza erotica nell’universo sicuramente è un punto di primaria importanza. Inoltre i miti trasferiscono immagini della divinità senza le quali correremmo il rischio di perdere tutti i colori, le informazioni di ogni Dio, rivolgendoci ad un generico, non caratterizzato nume.
Alla fine dell’inseguimento, Dafne preferisce sfuggire al suo spasimante, chiedendo aiuto (fer opem) a suo padre. Tuttavia nel disegno di Ovidio i numi fluviali, a differenza delle divinità olimpiche e titaniche, non hanno il potere di eseguire trasformazioni. Forse per questo motivo interviene Tellus in soccorso alla fanciulla, trasformandola in un alloro. Alla fine la parte umana dentro l’alloro si tranquillizza nel disegno più nobile del Dio. Ovidio lascia non risolto se il trionfo di Apollo è la sconfitta o la vittoria di Dafne. Un’ambiguità abbastanza comune che forse non ha risposta.
Questa sezione delle metamorfosi, oltre a presentare una parte etica, una naturalistica e una elegiaca, offre anche la spiegazione di varie usanze seguendo lo stile eziologico di Callimaco e della scuola Alessandrina: la fondazione dei giochi pitici, il motivo per cui durante quei giochi si offriva un ramo di quercia anziché di alloro, la narrazione di come l’alloro sia divenuta la pianta sacra ad Apollo e sempreverde, e con l’accenno ai trionfi e alla dimora di Augusto riporta il lettore al tempo in cui l’opera veniva scritta.
Un racconto intenso, che ci fa ricordare di innamoramenti strazianti, sofferenze senza rimedio, situazioni illusorie, ma soprattutto ci fa constatare che, per quanto possiamo sforzarci, la vita non consta di solo eventi razionali, ma anche di energie dirompenti che possono far cambiare improvvisamente il corso degli eventi accuratamente pianificati. E se passando accanto ad una pianta d’alloro vi sembrerà di percepire un fremito, già ne conoscete la ragione.
Mario Basile
(Fori Hadriani scripsit, Id. Nov. MMDCCLXXII)